
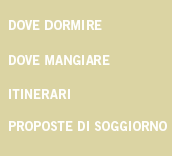
LA CAPPELLA TIRANNI DI GIOVANNI SANTI PADRE DI RAFFAELLO
Chiesa di San Domenico Via: Lapis n. Citta' : Cagli (centro storico) Prov.: PU
Nella vasta aula della chiesa di San Domenico a Cagli e' la nota Cappella Tiranni la cui decorazione fu affidata da Pietro Tiranni a Giovanni Santi e che Pungileoni considerava "il suo capo lavoro" indicandola come la "bell'opera che fu l'estremo di sua possa". Passavant dal canto suo affermava che "questa pittura " senza dubbio l'opera piu' grandiosa e piu' bella che ci sia rimasta del Santi, il quale valeva assai meglio nell'affresco che nella tempera, poiche' qui il disegno e' piu' largo, il colorito piu' armonioso e nelle carni piu' vivo". La cappella e' fin dal secolo scorso una delle mete di visita per i viaggiatori inglesi che transitano lungo la Flaminia. D'altronde Austen Henry Layard aveva pubblicato fin dal 1859 per conto della "Arundel Society" una monografia intitolata Giovanni Sanzio and his fresco at Cagli", tradotta pero' in italiano solo nel 1994. Tutta la concezione dell'altare (le lesene e le colonne, con tracce di una decorazione pittorica a fogliame, poste su alti piedistalli che sorreggono le mensole ove poggia un arco a tutto sesto con forte aggetto) elegante ed armoniosa, si direbbe opera del Santi. Nei due tondi dei pennacchi dell'arco, immediatamente sotto il fregio dipinto a motivi classici dell'architrave, e' l'Annunciazione. Nella parete di fondo sono poi la Sacra Conversazione e la Resurezione di Cristo.
Al centro di un'architettura sapientemente collegata a quella esteriore, la Madonna col
Chiesa di San Domenico Via: Lapis n. Citta' : Cagli (centro storico) Prov.: PU
Nella vasta aula della chiesa di San Domenico a Cagli e' la nota Cappella Tiranni la cui decorazione fu affidata da Pietro Tiranni a Giovanni Santi e che Pungileoni considerava "il suo capo lavoro" indicandola come la "bell'opera che fu l'estremo di sua possa". Passavant dal canto suo affermava che "questa pittura " senza dubbio l'opera piu' grandiosa e piu' bella che ci sia rimasta del Santi, il quale valeva assai meglio nell'affresco che nella tempera, poiche' qui il disegno e' piu' largo, il colorito piu' armonioso e nelle carni piu' vivo". La cappella e' fin dal secolo scorso una delle mete di visita per i viaggiatori inglesi che transitano lungo la Flaminia. D'altronde Austen Henry Layard aveva pubblicato fin dal 1859 per conto della "Arundel Society" una monografia intitolata Giovanni Sanzio and his fresco at Cagli", tradotta pero' in italiano solo nel 1994. Tutta la concezione dell'altare (le lesene e le colonne, con tracce di una decorazione pittorica a fogliame, poste su alti piedistalli che sorreggono le mensole ove poggia un arco a tutto sesto con forte aggetto) elegante ed armoniosa, si direbbe opera del Santi. Nei due tondi dei pennacchi dell'arco, immediatamente sotto il fregio dipinto a motivi classici dell'architrave, e' l'Annunciazione. Nella parete di fondo sono poi la Sacra Conversazione e la Resurezione di Cristo.
Al centro di un'architettura sapientemente collegata a quella esteriore, la Madonna col

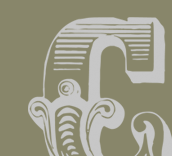

Bambino dritto sulle ginocchia, e' attorniata da quattro figure di Santi. La Vergine con
il crine rannodato da un velo, e' assisa su di un trono marmoreo dal cui architrave,
decorato con tre fioroni dorati, pende una corona d'oro gemmata. Eleganti sono le mensole e i piedistalli a fogliami dorati, nonche' le decorazioni a candelabre dei due pilastri.
Il trono e' poi arricchito da festoni che pendono da ambo i lati, mentre il solo sedile e' ricoperto da un ricco tessuto.
Alla sinistra del visitatore, vestito con una preziosa tonaca e sopraveste di tessuto e ricami dorati, e con il viso rivolto al popolo, e' San Pietro che mostra la chiave d'oro legata a quella d'argento. Segue San Francesco riconoscibile per le stimmate dalle quali partono dei raggi dorati con il modesto saio dal rude cordone a tre nodi che simboleggiano i voti di poverta', castita' ed obbedienza. Il poverello d'Assisi reca pure in mano il crocifisso che in questo caso si direbbe elevato quasi a protezione del vicino angelo, che ha ali lumeggiate d'oro ed una veste preziosa quanto leggera. Questa creatura celeste che con espressione vivace volge lo sguardo verso il visitatore, e' tradizionalmente ritenuta il ritratto di Raffaello all'eta' di nove anni.
Dopo la Madonna, nella quale si e' inteso ravvisare un forte influsso del Perugino dimenticando gli esempi marchigiani dei crivelleschi, e San Tommaso d'Aquino distinguibile rispetto a San Domenico per il piccolo sole che splende sul petto. Infine e' l'emaciato San Giovanni Battista, il cui volto secondo alcuni sarebbe l'autoritratto del Pittore, e al quale era in antico dedicata l'odierna chiesa di San Domenico in Cagli.
Sul pavimento le ampolle utilizzate per la Santa Messa, alludono al sacrificio del Cristo mentre la fiamma della candela, posta al centro del semicerchio idealmente realizzato dagli astanti, sta ad indicare la possibilita' della vita eterna attraverso la fede nonche' la resurrezione resa possibile dal sacrifico del Salvatore.
In linea con la candela accesa e' poi in alto il Cristo Risorto davanti al sepolcro tra due ale di soldati, con corazze di foggia tipicamente quattrocentesca e secondo taluni feltresca, immobilizzati dallo straordinario evento. Nel vedere le sei guardie il Passavant annotava che erano disposte "in varie posizioni e scorti bellissimi da emulare il suo amico Melozzo da Forli', che Giovanni ammirava, massimamente per quella sua arte di scortare le figure".
E' stato evidenziato dal Varese, il collegamento esistente tra questa parte di affresco e la Resurrezione che il Perugino dipinse piu' tardi, precisamente intorno al 1496 (il Santi muore nel 1494), per il monastero di San Pietro, e che oggi si trova al museo di Rouen.
Infine al centro del sottarco e' il Cristo benedicente, tra un coro di angeli musicanti. La coppia di angeli di sinistra canta e suona un triangolo ed un liuto, mentre quella di destra reca un cornetto diritto ed una ribecca di taglia soprano, quest'ultima impiegata in particolare nelle danze o abbinata nel canto al rispettivo registro vocale.
La datazione tradizionale ai primi anni '90 viene anticipata dal Varese al periodo 1481-1484.
Se cosi' fosse al Santi andrebbe allora tributato il merito di aver fatto "confluire nell'operare figurativo che si esprimeva nelle Marche il respiro ed i modi piu' larghi che aveva appreso a Firenze e a Roma". Resta aperto il dibattito sulla datazione della Cappella Tiranni del Pittore che aveva assunto quale punto di riferimento il Mantegna, ovvero l'artista nel quale "si fondono, con esiti alti, i due tronconi nei quali era divisa, a parere del Santi, la cultura figurativa del suo tempo: il filone cortese e quello prospettico di matrice toscana".
Occorre infine rimarcare come lo studio dei guerrieri raffigurati nella scena della Resurrezione ha condotto di recente Fausta Gualdi ad individuare citazioni dell' opera paterna da parte del giovane Raffaello nella predella della Crocifissione Gavari (Lisbona, Museu National de Arte Antiga). La studiosa ha peraltro ravvisato anche precisi rimandi esistenti nella Resurrezione di Cristo (San Paolo del Brasile, Museo) di Raffaello con il fastigio del sarcofago di Battista Tiranni del 1481 posto sotto l' altro affresco di Giovanni Santi presente nella medesima chiesa di San Domenico. Le due opere cagliesi commissionate entrambe da Pietro Tiranni, dunque, testimoniano l' influenza subita dal giovane Raffaello sia attraverso l' assunzione dei primi insegnamenti e sia mediante una sorta di apprendistato visivo generato dalla profonda conoscenza delle opere paterne: cio' sottolinea, dunque, l' importanza di Giovanni Santi per la formazione del figlio.
La Cappella Tiranni e' stata sottoposta per l' occasione della mostra ad un restauro seguito dall' IsCR di Roma e finanziato da Confindustria di Pesaro-Urbino.
Alberto Mazzacchera
Bibliografia essenziale
L. PUNGILEONI, Elogio storico di Giovanni Santi pittore e poeta padre del gran Raffaello di Urbino, Urbino 1822.
J. D. PASAVANT, Raffaello di Urbino e il padre suo Giovanni Santi opera tradotta, corredata di note e di una notizia biografica dell' autore da Gaetano Guasti, Firenze 1882.
A. H. LAYARD, Giovanni Santi e l' affresco di Cagli a cura di Ranieri Varese, Firenze 1994.
R. VARESE, Giovanni Santi, Fiesole 1994.
A. MAZZACCHERA, Il forestiere in Cagli. Palazzi, chiese e pitture di una antica citta' e terre tra Catria e Nerone, Urbania 1997.
F. GUALDI, "Per Pintoricchio e Raffaello Giovane. Nuovi esiti di ricerche e "adornament" libri, animali, oreficerie", Accademia Raffello. Atti e Studi, Anno 2007, n. 2 (dic. 2007).
il crine rannodato da un velo, e' assisa su di un trono marmoreo dal cui architrave,
decorato con tre fioroni dorati, pende una corona d'oro gemmata. Eleganti sono le mensole e i piedistalli a fogliami dorati, nonche' le decorazioni a candelabre dei due pilastri.
Il trono e' poi arricchito da festoni che pendono da ambo i lati, mentre il solo sedile e' ricoperto da un ricco tessuto.
Alla sinistra del visitatore, vestito con una preziosa tonaca e sopraveste di tessuto e ricami dorati, e con il viso rivolto al popolo, e' San Pietro che mostra la chiave d'oro legata a quella d'argento. Segue San Francesco riconoscibile per le stimmate dalle quali partono dei raggi dorati con il modesto saio dal rude cordone a tre nodi che simboleggiano i voti di poverta', castita' ed obbedienza. Il poverello d'Assisi reca pure in mano il crocifisso che in questo caso si direbbe elevato quasi a protezione del vicino angelo, che ha ali lumeggiate d'oro ed una veste preziosa quanto leggera. Questa creatura celeste che con espressione vivace volge lo sguardo verso il visitatore, e' tradizionalmente ritenuta il ritratto di Raffaello all'eta' di nove anni.
Dopo la Madonna, nella quale si e' inteso ravvisare un forte influsso del Perugino dimenticando gli esempi marchigiani dei crivelleschi, e San Tommaso d'Aquino distinguibile rispetto a San Domenico per il piccolo sole che splende sul petto. Infine e' l'emaciato San Giovanni Battista, il cui volto secondo alcuni sarebbe l'autoritratto del Pittore, e al quale era in antico dedicata l'odierna chiesa di San Domenico in Cagli.
Sul pavimento le ampolle utilizzate per la Santa Messa, alludono al sacrificio del Cristo mentre la fiamma della candela, posta al centro del semicerchio idealmente realizzato dagli astanti, sta ad indicare la possibilita' della vita eterna attraverso la fede nonche' la resurrezione resa possibile dal sacrifico del Salvatore.
In linea con la candela accesa e' poi in alto il Cristo Risorto davanti al sepolcro tra due ale di soldati, con corazze di foggia tipicamente quattrocentesca e secondo taluni feltresca, immobilizzati dallo straordinario evento. Nel vedere le sei guardie il Passavant annotava che erano disposte "in varie posizioni e scorti bellissimi da emulare il suo amico Melozzo da Forli', che Giovanni ammirava, massimamente per quella sua arte di scortare le figure".
E' stato evidenziato dal Varese, il collegamento esistente tra questa parte di affresco e la Resurrezione che il Perugino dipinse piu' tardi, precisamente intorno al 1496 (il Santi muore nel 1494), per il monastero di San Pietro, e che oggi si trova al museo di Rouen.
Infine al centro del sottarco e' il Cristo benedicente, tra un coro di angeli musicanti. La coppia di angeli di sinistra canta e suona un triangolo ed un liuto, mentre quella di destra reca un cornetto diritto ed una ribecca di taglia soprano, quest'ultima impiegata in particolare nelle danze o abbinata nel canto al rispettivo registro vocale.
La datazione tradizionale ai primi anni '90 viene anticipata dal Varese al periodo 1481-1484.
Se cosi' fosse al Santi andrebbe allora tributato il merito di aver fatto "confluire nell'operare figurativo che si esprimeva nelle Marche il respiro ed i modi piu' larghi che aveva appreso a Firenze e a Roma". Resta aperto il dibattito sulla datazione della Cappella Tiranni del Pittore che aveva assunto quale punto di riferimento il Mantegna, ovvero l'artista nel quale "si fondono, con esiti alti, i due tronconi nei quali era divisa, a parere del Santi, la cultura figurativa del suo tempo: il filone cortese e quello prospettico di matrice toscana".
Occorre infine rimarcare come lo studio dei guerrieri raffigurati nella scena della Resurrezione ha condotto di recente Fausta Gualdi ad individuare citazioni dell' opera paterna da parte del giovane Raffaello nella predella della Crocifissione Gavari (Lisbona, Museu National de Arte Antiga). La studiosa ha peraltro ravvisato anche precisi rimandi esistenti nella Resurrezione di Cristo (San Paolo del Brasile, Museo) di Raffaello con il fastigio del sarcofago di Battista Tiranni del 1481 posto sotto l' altro affresco di Giovanni Santi presente nella medesima chiesa di San Domenico. Le due opere cagliesi commissionate entrambe da Pietro Tiranni, dunque, testimoniano l' influenza subita dal giovane Raffaello sia attraverso l' assunzione dei primi insegnamenti e sia mediante una sorta di apprendistato visivo generato dalla profonda conoscenza delle opere paterne: cio' sottolinea, dunque, l' importanza di Giovanni Santi per la formazione del figlio.
La Cappella Tiranni e' stata sottoposta per l' occasione della mostra ad un restauro seguito dall' IsCR di Roma e finanziato da Confindustria di Pesaro-Urbino.
Alberto Mazzacchera
Bibliografia essenziale
L. PUNGILEONI, Elogio storico di Giovanni Santi pittore e poeta padre del gran Raffaello di Urbino, Urbino 1822.
J. D. PASAVANT, Raffaello di Urbino e il padre suo Giovanni Santi opera tradotta, corredata di note e di una notizia biografica dell' autore da Gaetano Guasti, Firenze 1882.
A. H. LAYARD, Giovanni Santi e l' affresco di Cagli a cura di Ranieri Varese, Firenze 1994.
R. VARESE, Giovanni Santi, Fiesole 1994.
A. MAZZACCHERA, Il forestiere in Cagli. Palazzi, chiese e pitture di una antica citta' e terre tra Catria e Nerone, Urbania 1997.
F. GUALDI, "Per Pintoricchio e Raffaello Giovane. Nuovi esiti di ricerche e "adornament" libri, animali, oreficerie", Accademia Raffello. Atti e Studi, Anno 2007, n. 2 (dic. 2007).












